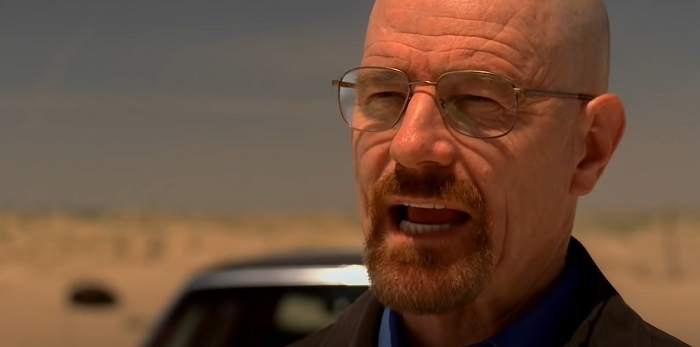Immaginate di essere seduti su una panchina insieme a un vostro amico. Davanti a voi, in un laghetto artificiale, uno stormo di una dozzina di anatre si rinfresca. Le anatre sono tutte di colore bianco, tranne una, che presenta un variopinto piumaggio striato. A un certo punto, proprio quest’ultima si immerge nell’acqua e riemerge con un pesciolino nel becco. Istintivamente, vi girate verso il vostro amico:
“Ehi, hai visto?”
“Che?”
“Quell’anatra! Hai visto come quell’anatra ha acchiappato il pesciolino?”
“No… Ma quale anatra?”
“Quella striata!”
“Oh… No, me la sono persa.”
Paris Saint Germain – Basaksehir
Ora immaginiamo un’altra scena. Siamo in un campo di calcio, in una fredda serata di dicembre di fine 2020. Si gioca un match di Champions League. Un incontro apparentemente di scarso interesse, se consideriamo che la partita mette di fronte una delle squadre più ricche del mondo, i padroni di casa del Paris Saint Germain, e una Cenerentola del calcio mondiale, una carneade turca dal nome impronunciabile, il Basaksehir.
Cosa potrebbe mai accendere i riflettori su una contesa dall’esito così scontato? Magari un colpo a sorpresa in stile Hollywood in cui la squadretta ospite mette KO i blasonati rivali? Mmmh, banale, cliché. Succede qualcosa di molto più significativo, molto più mediatico: un episodio di razzismo.
Siamo a inizio partita, il risultato è ancora di zero a zero. A un certo punto, l’arbitro viene richiamato a bordo campo: un calciatore della compagine di Istanbul che siede in panchina, Demba Ba, si comporta in modo animato, protesta, sbraccia. Con chi ce l’ha? Servono alcuni lunghissimi secondi per capirlo. Non c’è pubblico, conseguenza delle limitazioni imposte dal Covid, il silenzio ovattato si fa ancora più surreale e accoglie, imbarazzato, le rimostranze del calciatore. Intanto gli altri giocatori in campo, straniti, cercano di comprendere cosa stia succedendo: “Pare che il quarto uomo abbia detto una frase razzista”.
La voce, sibillina, si fa strada tra i presenti. La partita viene interrotta. I giocatori, prescindendo dal colore della loro divisa e da quello della loro pelle, si mostrano solidali con le proteste di Demba Ba. Ed è giusto così, perché il razzismo non può essere tollerato. Né può essere tollerata alcuna espressione che dia spazio a discriminazione di genere, razza, orientamento sessuale e religioso. Pochi minuti di bagarre, ma nel frattempo la notizia è già di dominio pubblico: quel bastardo razzista del quarto uomo ha usato la parola che non deve essere mai pronunciata. Tutti noi, da casa, davanti al PC, sui social, ci uniamo nel disgusto.
Beatrice Venezi a Sanremo
Terza scena: Venerdì 5 marzo. Quarta e penultima puntata di Sanremo 2021. Uno degli ospiti di serata è Beatrice Venezi, che con i suoi 31 anni appena, è annoverata tra i talenti più precoci delle direzione d’orchestra mondiale. Donna, giovane, bellissima e sulla cresta dell’onda. Non serve un grande sforzo per riconoscere in lei una funzione anche simbolica, catartica persino: lei è l’icona di un nuovo corso. La testimonianza di un mondo che vuole finalmente progredire, vuole andare in una nuova ‘direzione’, appunto.
Beatrice Venezi sdogana e incarna le sacrosante rivendicazioni di pari diritti e opportunità all’interno di un mondo che è molto, molto più patriarcale di quanto gran parte di noi uomini sarebbe disposto ad ammettere. Non per ciò che possa dire, ma per ciò che è. Lei è una donna che si è fatta strada, fino al vertice, di un sistema fino a poco tempo fa appannaggio quasi esclusivamente maschile. La sua esistenza è un atto comunicativo. Per dirlo con le parole del sociologo Marshall McLuhan, Beatrice Venezi è medium e messaggio. Ma oggigiorno non basta ciò che siamo a caratterizzarci come persone. Né cosa diciamo. Conta tantissimo la forma, è importante come lo diciamo. E durante la sua ospitata alla kermesse ligure, lei dice questo:
“La posizione ha un nome preciso e nel mio caso è quello di direttore d’orchestra, non di direttrice.”
Con queste semplici parole, la Venezi ha esternato la sua scelta di essere chiamata ‘Direttore’, non ‘Direttrice’. Apriti cielo. I social si scatenano, tra chi parla di “occasione persa” per tutto l’universo femminile e chi la accusa di aver rinunciato a una battaglia che dovrebbe essere LA battaglia di tutte le donne e di tutti gli uomini che credono in un mondo più equo, più paritario. Più meritocratico.
Il Politically Correct e l’ipocrisia
Vi ho raccontato tre episodi, neppure nella loro interezza: il primo è un fatto verosimile, banalissimo. Il secondo e il terzo sono fatti realmente accaduti, tratti dal nostro recente passato. Ciò che accomuna – o ciò che vorrei accomunasse – i tre episodi è un discorso sul linguaggio e sul valore del politicamente corretto. L’opinione che sto per esporre è che stiamo sopravvalutando la forza del linguaggio. E allo stesso tempo stiamo sottovalutando la forza del linguaggio. Cerchiamo intanto di non creare equivoci: il politically correct è un valore, una direzione verso cui tendere. Allo stesso tempo, però, esso è il fine del nostro percorso, non il mezzo.
Dico questo perché la mia personale opinione è che, con un velo neppure troppo sottile di ipocrita e sommario senso della giustizia, si voglia utilizzare il linguaggio per piegare la realtà al proprio volere. Come se chiamando un oggetto con un altro nome, lo si trasformasse in qualcosa che non è.
Stiamo sopravvalutando il linguaggio
Cerco di evitare un ulteriore possibile equivoco: le parole sono importanti. Il linguaggio esprime il livello di civilizzazione di un popolo, le sue conquiste, le sue battaglie perse. La comunicazione e il lessico evolvono, devono evolvere, perché sono lo specchio di una società che fa altro e tanto. E proprio questo è il punto: il linguaggio, da solo, non basta a porre in essere un cambiamento né può anticiparlo. La conquista di un vocabolario politicamente corretto deve essere perpetrata attraverso lotte di altro tipo, che hanno a che fare con il nostro modo di pensare, prima che con quello di esprimerci. Va cambiato il pensiero, poi il linguaggio, perché il linguaggio deriva dal pensiero e non il contrario. Il linguaggio è importante, importantissimo, poiché rappresenta un cambiamento, non perché lo innesca.
Stiamo sottovalutando il linguaggio
Credo che in pochi abbiano compreso appieno la potenza del messaggio di Beatrice Venezi. Rivendicando il suo diritto di scegliere come essere chiamata, lei ha affermato la sua identità con una forza straordinaria. Ha dichiarato in mondovisione che non ha bisogno di un’etichetta linguistica per legittimare il suo essere donna e, allo stesso tempo, professionista. Qualcuno l’ha persino accusata di avere avuto una visione – buon dio – retrograda; io penso esattamente il contrario, ovvero che lei sia più avanti di tutti gli altri: la vera equità, di genere, di razza e di idee, la conquisteremo quando non avremo bisogno di un nome studiato a tavolino per dare forma alla nostra essenza. Lei è la dimostrazione che una donna ha gli stessi meriti, le stesse capacità e, soprattutto, le stesse opportunità dei suoi omologhi di sesso maschile. Nessun titolo, nessun appellativo può definire o sminuire ciò che siamo. Guardate al suo esempio, non alla nomenclatura del suo ruolo.
Il razzismo è nelle orecchie di chi ascolta
Siamo all’assurdo. Personalmente, non ho mai avuto il timore che il mio modo di esprimermi possa essere interpretato male. Non ho mai temuto di incappare in un’uscita razzista oppure omofoba. E la ragione è semplice: perché non credo di esserlo. Siamo all’assurdo perché oggi la fobia sociale di dire qualcosa che possa apparire come politicamente scorretto ci spinge a non chiamare le cose con il loro nome.
Riprendiamo l’episodio numero due: che cosa aveva detto il quarto uomo Coltescu di quel Paris Saint Germain – Basaksehir per fare arrabbiare così tanto Demba Ba? Il romeno (non è un dettaglio) Sebastian Coltescu, parlando tramite auricolare con l’arbitro di gara, anch’egli romeno, richiama la sua attenzione e gli chiede di espellere per proteste Pierre Webo, assistente dell’allenatore del club turco, reo di proteste troppo vibranti. L’arbitro non individua l’uomo da espellere e chiede al collega di indicargli a chi si riferisca. La sua risposta, in lingua rumena, è: “ala negru”, che tradotto letteralmente significa: “Quello nero”.
Capisco che a qualcuno possa sembrare un atteggiamento un po’ sprezzante. Cerchiamo però di contestualizzare il tutto: siamo in un campo di calcio, durante un match della competizione per club più importante del mondo. Non si possono commettere errori, la comunicazione deve essere chiara e immediata. Inoltre parliamo di un dialogo ‘privato’ tra un arbitro e il suo assistente. Occorre individuare la persona a cui sarà comminata una sanzione, non ci si può certo permettere di cacciare dal campo un innocente. La panchina, lì dove indica il quarto uomo, è costituita esclusivamente da uomini dai connotati caucasici, ad eccezione, appunto, di Webo. Sono tutti vestiti allo stesso modo e, checché ne pensiate, essere l’unica persona dalla pelle scura in mezzo a un gruppo di persone dalla pelle chiara è una caratteristica che ti distingue. Esattamente come essere un uomo dalla pelle chiara in un gruppo di persone dalla pelle scura farebbe dell’unico caucasico “quel bianco lì”. Esattamente come l’anatra con il piumaggio striato si distingue da quelle dalle cromature candide.
E allora perché abbiamo imparato ad avere paura di chiamare nero ciò che è nero? La mia interpretazione è che il pregiudizio esiste, ma è nelle orecchie di chi ascolta, non nella bocca di chi parla. Risentirsi perché un uomo di colore viene riconosciuto come tale è sinonimo di razzismo, ma da parte di chi se ne lamenta, perché significa che egli assegna all’aggettivo ‘nero’ un’accezione negativa e non neutra, come invece è.
Il razzismo è nelle orecchie di chi ascolta quando riconosciamo un valore dispregiativo a una distinzione effettuata su un piano prettamente visivo, manifesto, oggettivo.
Vogliamo davvero superare i limiti sociali basati sulle discriminazioni di colore, di genere, di ideali e di orientamenti? Allora smettiamola di avere paura delle differenze, ma chiamiamole con il loro nome e accogliamole come parte della nostra meravigliosa e multiforme normalità.